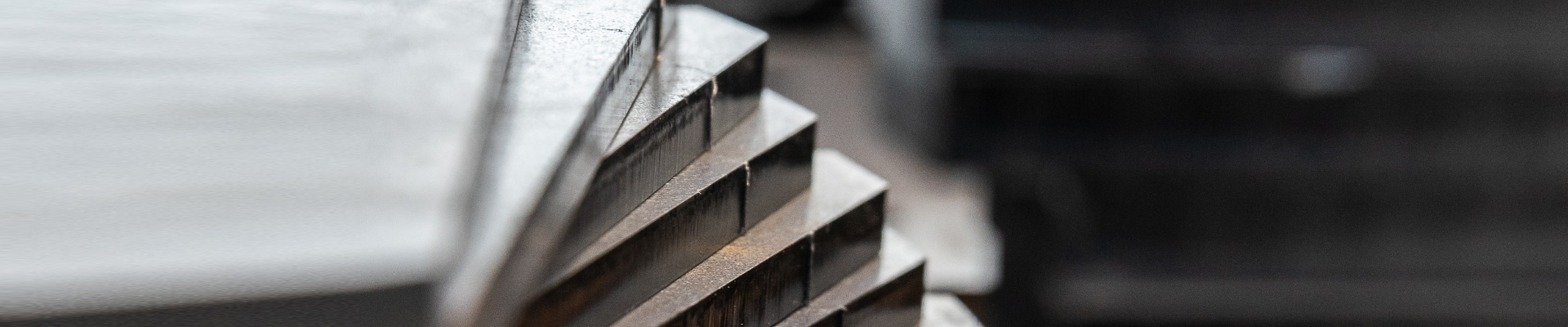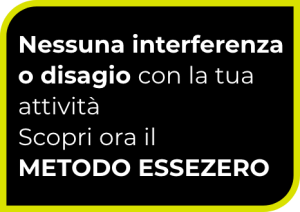July 14, 2025
Consolidamento strutturale edifici: nuove tecniche e soluzioni contro i sismi
Il consolidamento strutturale, a partire dall’analisi modale e dal conseguente progetto, comprende l’insieme di opere eseguite per ripristinare o incrementare la capacità portante di un edificio in vista di carichi statici e fattori ambientali, tra cui le azioni sismiche. L’intervento, finalizzato a estendere la vita utile della costruzione e a scongiurare criticità future, oggi assume un ruolo centrale per tre motivi: consente di accedere alla detrazione unica del 36 % (30 % dal 2026) prevista dal Sismabonus, può contribuire a ridurre il premio della polizza catastrofale divenuta obbligatoria e migliora il profilo ESG.

Il primo step: dall’analisi modale alla progettazione
Tra i diversi metodi e strumenti impiegati nelle fasi iniziali di analisi, l’intera mappatura dell’edificio oggetto di studio può essere affidata a un rilievo LIDAR, tecnologia con questa nomenclatura in quanto acronimo di “Light Detection and Ranging”. Questa tecnologia consente di effettuare in loco di telerilevamento per mezzo di impulsi laser al fine di creare modelli 3D ad alta risoluzione ed estremamente dettagliati di superfici, impianti e oggetti. Il modello geometrico ad alta risoluzione restituisce, in abbinamento alla documentazione raccolta risalente all’anno di costruzione ed a eventuali indagini effettuate, un quadro dettagliato della situazione di partenza. Incrociando le mappe delle massime sollecitazioni sismiche con il rilievo laser-scanner millimetrico, il team individua con esattezza i punti critici della struttura. Su queste basi vengono dimensionati rinforzi progettati ad hoc, calibrati per coesistere con le dorsali impiantistiche e mantenerle pienamente operative. La progettazione antisismica, infatti, non si esaurisce nel disegno del sistema di consolidamento: deve prevedere spazi di accesso per piattaforme aeree e mezzi di sollevamento, riducendo a monte interferenze di cantiere, tempi di posa e costi complessivi.
Principali tecniche di consolidamento strutturale per tipologia di edificio
Edifici in opera (muratura e calcestruzzo gettato in sito)
Nei fabbricati realizzati direttamente in cantiere – le strutture “in opera” in muratura portante o in calcestruzzo armato gettato su casserature tradizionali – la sicurezza sismica è spesso penalizzata da tre fattori ricorrenti: assenza di collegamenti trasversali fra pareti e solai, scarsa resistenza a taglio dei giunti di malta e irregolarità dei materiali posati decenni fa. Se la struttura portante è un telaio in c.a. possono emergere carenze a flessione o a taglio in travi e pilastri; nei setti in calcestruzzo dei vani scala o ascensore la concentrazione di rigidezza amplifica le sollecitazioni. Nelle murature portanti, invece, i problemi tipici riguardano la debole coesione dei giunti, il rischio di espulsione fuori piano e le lesioni diagonali.
Per ridurre queste vulnerabilità bisogna migliorare la coesione interna dei paramenti e garantire la trasmissione delle forze orizzontali senza alterare in modo significativo massa e rigidezza. Ecco alcune tecniche di consolidamento adatte a questa tipologia costruttiva:
- Iniezioni di miscele leganti:
L’intervento riempie interstizi e cavità aumentando la continuità e la resistenza della muratura; è efficace solo se si ottiene la saturazione completa dei vuoti con una diffusione omogenea della malta. - Cuci-scuci delle zone lesionate:
Sostituzione dei blocchi danneggiati con nuovi elementi ben ammorsati, restaurando la tessitura muraria. Richiede manodopera qualificata per evitare microfratture durante l’intervento e per garantire un’adeguata ammorsatura dei nuovi elementi, assicurando la continuità meccanica della parete. - Tiranti in acciaio inox pretensionati:
Collegano pareti contrapposte e solai, assicurando il cosiddetto “comportamento a scatola” e riducendo il rischio di ribaltamento fuori piano. La pretensione deve essere calcolata con precisione per non introdurre tensioni eccessive nelle murature fragili, evitando danni ai materiali esistenti. - Bande o barre in FRP/FRCM (carbonio, basalto):
Applicate su architravi, archi o fasce murarie, aumentano in modo significativo la capacità a taglio e flessione della parete senza gravare sui carichi permanenti. L’FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) è spesso preferito all’FRP in murature storiche per la maggiore compatibilità con i materiali tradizionali e la traspirabilità, garantendo una migliore integrazione con la struttura esistente.
Edifici prefabbricati in calcestruzzo armato
I capannoni prefabbricati in calcestruzzo armato costruiti tra gli anni ’60 e i primi 2000 basano gran parte della loro stabilità sull’attrito fra gli elementi: tegoli di copertura e travi di bordo, privi di fissaggi meccanici, appoggiano semplicemente sulle mensole dei pilastri. In caso di sisma l’attrito si annulla, gli appoggi possono essere persi e la copertura collassare. Per adeguare queste strutture alle richieste di sicurezza delle NTC 2018 è indispensabile inserire connessioni puntuali – piastre, barre passanti e dispositivi antisismici di contrasto allo scorrimento – che ancorino tegoli, travi e pannelli alla carpenteria verticale; solo così l’edificio può essere valutato e progettato come un sistema globale capace di redistribuire le forze sismiche.
- Controventi di falda con tiranti regolabili e lamiere grecate irrigidenti: trasformano la copertura in un diaframma rigido e redistribuiscono le forze agli elementi verticali. La progettazione dei controventi deve considerare la rigidezza relativa tra copertura e pilastri per evitare concentrazioni di sforzi, garantendo una distribuzione uniforme delle forze sismiche.
- Incamiciatura in calcestruzzo armato: getto di calcestruzzo autocompattante con barre aggiuntive ancorate, utile ad aumentare sezione e duttilità dei pilastri. Richiede un’attenta progettazione della connessione tra pilastro esistente e ringrosso, per garantire l’ancoraggio delle barre ed evitare discontinuità meccaniche.
- Incamiciatura in acciaio (placche o calastrelli): incrementa la capacità portante senza variare significativamente l’ingombro, utile in corsie di movimentazione ristrette. È necessario considerare la protezione anticorrosione delle placche in acciaio, specialmente in ambienti aggressivi, per garantire la durabilità.
- Dispositivi antisismici sugli appoggi dei tegoli:: questi dispositivi, installati in corrispondenza degli appoggi di tegoli o travi di copertura, assorbono e dissipano l’energia del terremoto trasformandola in calore, riducendo così le sollecitazioni che arrivano agli elementi strutturali e prevenendo la perdita di appoggio.

Edifici prefabbricati in acciaio
I capannoni monopiano in acciaio, seppur caratterizzati da leggerezza costruttiva ed elevata duttilità, presentano comunque alcune vulnerabilità tipiche sotto azione sismica. Le colonne a sezione H e le travi a parete sottile, infatti, possono sviluppare deformazioni localizzate in corrispondenza delle anime sottili, mentre i giunti bullonati o saldati fra travi, controventi e colonne tendono a comportarsi da nodi flessibili se la bulloneria è di classe bassa o la saldatura non è continua. A queste criticità si aggiunge il rischio di instabilità o buckling degli elementi troppo snelli, che riduce la capacità portante soprattutto in compressione.Il tutto deve essere progettato in modo da limitare l’incremento di peso—e quindi di azione sismica e sovraccarico sulle fondazioni—per non vanificare i vantaggi intrinseci della struttura in acciaio.
I possibili interventi possono riguardare:
- Controventi di parete (o di falda): irrigidiscono il telaio nel proprio piano, riducendo le deformazioni sotto carichi sismici. La scelta tra tubolari e profili HEA dipende dalla geometria e dalla capacità portante richiesta, garantendo un’adeguata integrazione con la struttura esistente.
- Rinforzo dei nodi fra gli elementi strutturali: la soluzione più diffusa consiste nell’applicare piastre metalliche al nodo trave-colonna per aumentarne resistenza e rigidezza; tali piastre vengono saldate o imbullonate alla struttura esistente da personale qualificato, in modo da garantire la qualità dell’esecuzione e la durabilità della connessione.
- Rinforzo colonne ad elevata snellezza: l’intervento consiste nel saldare o imbullonare piastre aggiuntive lungo i fianchi della colonna per aumentare la sezione resistente e migliorare la stabilità globale senza dover sostituire l’elemento.
- Lamelle CFRP incollate sull’anima delle travi a parete sottile: incrementano la resistenza a flessione e ritardano il buckling locale sotto compressione. L’applicazione richiede superfici pulite e un’adesione perfetta per evitare delaminazioni, garantendo l’efficacia del rinforzo.
Iter autorizzativo e documentazione per il Sismabonus 36 %
Il consolidamento strutturale rientra negli interventi agevolati dal Sismabonus: per gli edifici esistenti situati in zona sismica 1, 2 o 3 è possibile detrarre il 36 % (30 % dal 2026) delle spese sostenute, fino a 96 000 € per unità. Per usufruirne basta che il progetto dimostri un effettivo miglioramento della sicurezza sismica – cioè una riduzione della vulnerabilità certificata da un tecnico abilitato – e che i pagamenti avvengano con bonifico tracciabile dedicato e parlante. Oltre ai lavori veri e propri, la detrazione copre anche le spese di analisi, progettazione e verifica finale dell’intervento.
Che si tratti di consolidamento in muratura, di rinforzi in cemento armato o di applicazioni con fibre di carbonio, un progetto strutturale calibrato trasforma l’obbligo di sicurezza in un investimento che unisce detrazioni fiscali, contributi a fondo perduto, riduzione dei premi assicurativi e valorizzazione immobiliare. Gli interventi di consolidamento strutturale rappresentano quindi una strategia concreta per rafforzare la resilienza dell’azienda, garantire continuità operativa e proteggere persone e beni in un territorio ad alto rischio sismico.
Per ricevere informazioni e prenotare una consulenza per il tuo capannone, contattaci.